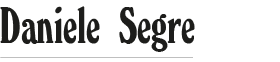Gianni Canova
Un gabinetto pubblico seminterrato. Luci al neon fredde e raggelanti. Sei orinatoi sulla parete di fondo. E un’aria intrisa di olezzi aspri e di acidi urici, residui olfattivi di minzioni incontenibili e frettolose. Mitraglia e il Verme si svolge tutto qui: apparentemente fuori dal mondo, in realtà in uno spazio-latrina che assorbe in sé tutto il tanfo e l’orrore del mondo, o di quel che il mondo è ormai diventato. Qui, in un bianco e nero gelido e freddo come lo spazio che rappresenta, due personaggi inscenano una sorta di dolente e furente teatro dell’assurdo. Mitraglia – che lavora alle dipendenze dei Mercati Generali, e gestisce il traffico dei prodotti ortofrutticoli – è grosso e incontinente, è sempre attaccato al cellulare, sdolora per i calcoli ai reni e si avventa sugli orinatoi come un uccello rapace sulla preda. Il Verme, invece, è il guardiano dei cessi: magro e stecchito, con alle spalle un passato di dignità borghese decaduta, fa citazioni in latino ma non si stacca un attimo dalla ramazza con cui pulisce incessantemente il pavimento, mentre affida al vizio del gioco – e in particolare alle scommesse ippiche – l’unica residua speranza di poter migliorare la sua condizione. Anche se sembrano larve beckettiane, i due protagonisti del nuovo film di Daniele Segre non sono emarginati, disoccupati, clochard. Sono piuttosto nuovi poveri: due dei tanti che, pur avendo un lavoro, una casa e uno stipendio, vengono spinti ai margini dai processi incalzanti della globalizzazione. Tanto che per sopravvivere uno (Mitraglia) presta denaro a usura, l’altro (il Verme) sogna di azzeccare un pronostico all’ippodromo, anche se è perfettamente consapevole che «non c’è niente, ma proprio niente, da sognare». Diviso in tre atti, ognuno risolto in un unico piano sequenza a macchina fissa e frontale, Mitraglia e il Verme è uno dei film italiani più interessanti della stagione: per la radicalità della messinscena, per il coraggio e la voglia di sperimentare, per la straordinaria performance dei due unici attori. Riprendendo e aggiornando il modello di “finzione” già sperimentato in Vecchie (2002), il documentarista Daniele Segre abbandona momentaneamente il “cinema della realtà” per addentrarsi nei territori di un apologo (o di una parabola) che ambisce a far emergere il reale (con tutte le sue ferite laceranti e le sue contraddizioni stridenti) attraverso una messinscena che oscilla tra Fassbinder e Bertolt Brecht. I festival italiani – a cominciare da Venezia – non l’hanno voluto: il che la dice lunga sul conformismo di chi li dirige e sul servilismo con cui quasi tutti ormai si piegano ai poteri forti e ai canoni di gusto dominanti.